Cooperazione o neocolonialismo?
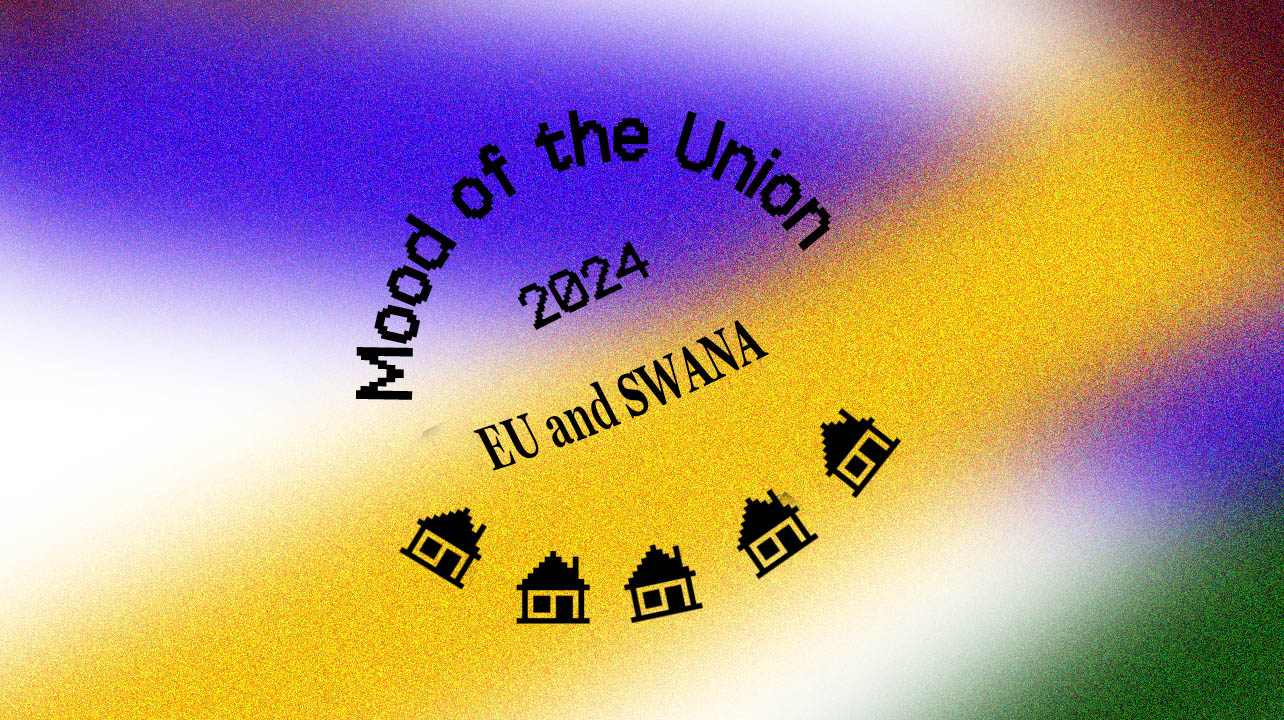
Negli ultimi anni, l’Unione europea (UE) ha consolidato la sua posizione di attore globale, spronata da sfide acute come la pandemia COVID-19 e il conflitto in corso tra Russia e Ucraina. Queste crisi hanno spinto a rivalutare la politica estera dell’UE. Nel processo, la distinzione tra sfera politica interna e internazionale è stata sfumata, illustrando come le elezioni e le politiche nazionali possano avere effetti di vasta portata sulle dinamiche globali.
Un’area centrale di interconnessione è l’approccio dell’UE alla migrazione, che è fondamentale per la sua politica estera, soprattutto dopo la “crisi dei rifugiati del 2015″. Da allora, oltre 2,39 milioni di migranti hanno attraversato il Mediterraneo per raggiungere l’Europa, suscitando un’intensa attenzione politica sulla gestione della migrazione, spesso inquadrata come “gestione”, che coinvolge principalmente gli Stati mediterranei meridionali non appartenenti all’UE e all’UE.
Il discorso sulla migrazione ha subito un’impennata e un sondaggio del Consiglio europeo per le relazioni estere del gennaio 2024 indica che l’immigrazione è una preoccupazione significativa all’interno dell’UE. L’estrema destra ha capitalizzato su questo tema, portando i partiti mainstream in tutta Europa a spostare le loro posizioni sull’immigrazione per contrastare quella che è diventata una seria sfida elettorale.
Questo cambiamento si è riflesso a livello europeo. Il blocco ha sempre più adottato una politica estera transazionale che ruota attorno agli accordi di esternalizzazione, rivolgendosi principalmente ai Paesi mediterranei non appartenenti all’UE, cruciali sia come origine che come punto di transito dei migranti, tra cui la Turchia, l’Egitto, la Tunisia e il Libano. Spesso chiamati accordi in cambio di controllo questi accordi motivano finanziariamente i Paesi a gestire la migrazione ai confini dell’UE.
Oltre alla migrazione, l’UE sta espandendo la sua collaborazione con questi partner extra-UE in settori quali il commercio, la sicurezza energetica e la decarbonizzazione. La Presidente della Commissione Ursula von der Leyen sta attivamente stringendo nuovi partenariati prima della conclusione del suo mandato, con l’obiettivo di approfondire i legami. Tuttavia, questi sforzi sollevano interrogativi sulle motivazioni politiche sottostanti e sull’equilibrio dei benefici tra l’UE e i suoi partner mediterranei non UE. Si teme inoltre che questi accordi possano sostenere i regimi repressivi fornendo loro ulteriore legittimità e aiuti economici, che saranno utilizzati per rafforzare ulteriormente il loro potere.
Siria
La guerra in Siria è stata un punto focale della politica estera dell’UE nell’ultimo decennio. La guerra è scoppiata nel 2011 dopo che il governo aveva represso le proteste pacifiche a favore della democrazia, causando più di mezzo milione di morti e sfollando circa metà della popolazione. Più di un decennio dopo, con gran parte del territorio recuperato dalle forze governative siriane sostenute dagli alleati russi e iraniani, il conflitto persiste con nessuna fine in vista.
Il rifiuto del presidente della Siria Bashar al-Assad di negoziare con le fazioni della resistenza, insieme al coinvolgimento del regime in attività illecite come il traffico di droga per sostenere la sua economia vacillante, complica ulteriormente la prospettiva di pace.Gli sforzi di pace guidati dalle Nazioni Unite, compresi i tentativi di redigere una nuova costituzione, non sono riusciti a ottenere trazione. La riammissione della Siria nella Lega Araba e il graduale ripristino dei legami regionali rendono sempre più improbabile la prospettiva di porre fine al conflitto in termini non dettati da Assad.
Oggi la politica siriana dell’UE continua a essere guidata dalla Strategia sulla Siria, un documento adottato dal Consiglio nell’aprile 2017. Dal punto di vista politico, questa strategia sottolinea la posizione dell’UE contro la normalizzazione delle relazioni con il regime siriano e il suo impegno a mantenere le sanzioni. Sul fronte umanitario, il documento sottolinea l’impegno dell’UE in Siria. L’UE e i suoi Stati membri continuano ad essere i maggiori donatori della Siria, avendo contribuito con oltre 30 miliardi di euro in assistenza umanitaria ed economica dall’inizio della guerra.
Le sanzioni dell’UE prendono di mira individui ed entità legati ad attività illecite e alla violenta repressione del popolo siriano. Mirate a limitare le risorse finanziarie del regime e a fare pressione su Assad affinché attui riforme politiche, le sanzioni non hanno ancora sortito gli effetti desiderati e la loro efficacia e il loro impatto sulla popolazione siriana restano oggetto di dibattito all’interno dell’UE. Nonostante le sanzioni, l’Unione Europea è il più grande partner commerciale.
Da quando la guerra è iniziata nel 2011, oltre 14 milioni di siriani sono stati sfollati, con più di 7,2 milioni attualmente sfollati internamente. I Paesi vicini come la Turchia, il Libano, la Giordania, l’Iraq e l’Egitto ospitano complessivamente circa 5,5 milioni di rifugiati siriani, mentre la Germania è il più grande Paese di destinazione dell’UE, con oltre 850.000 posti.
Giunto al tredicesimo anno, la guerra in Siria è stata esacerbata dal collasso economico, dalla perdita dei mezzi di sussistenza, dal persistente siccità e il devastante terremoto del 2023, che ha fatto salire la crisi umanitaria a livelli senza precedenti. Su 18 milioni di persone in Siria, 16,7 milioni sono bisognosi di assistenza umanitaria; se si include la diaspora, il numero supera i 30 milioni. Attualmente, oltre l’80% dei siriani vive al di sotto della soglia di povertà internazionale, un’escalation significativa rispetto al 10% registrato prima dell’inizio del conflitto. Nel 2024, significativi tagli ai finanziamenti del Programma Alimentare Mondiale hanno visto una diminuzione dell’80% del numero di siriani che ricevono assistenza alimentare, con gravi ripercussioni sulla nutrizione infantile e un ulteriore peggioramento della situazione.
Nonostante il perdurare della situazione umanitaria, diversi Paesi che ospitano rifugiati e richiedenti asilo siriani – tra cui il Libano, la Danimarca e la Türchia – hanno tentato di farli tornare in Siria. Si tratta di una mossa politica che è stata intensamente esaminata dalle organizzazioni della società civile. Un rapporto del febbraio 2024 OHCHR ha evidenziato le sofferenze dei rimpatriati, la cui situazione “solleva seri interrogativi sull’impegno degli Stati a garantire un giusto processo e il non respingimento”, secondo le parole dell’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Diritti Umani Volker Türk.
Ma di fronte alle numerose sfide dei Paesi ospitanti, centinaia di migliaia di rifugiati siriani fuggiti dalla guerra sono ritornati a casa, nonostante la triste situazione umanitaria e di sicurezza che li attende.
Turchia
Colpita dagli stessi devastanti terremoti del 2023, la Turchia sta sopportando una decennale recessione. L’inflazione ufficiale ha raggiunto quasi il 60%, collocando il Paese al quinto posto nel mondo, secondo il Fondo Monetario Internazionale (FMI). Mentre la lira turca crollava contro l’euro e il dollaro, i critici del presidente Recep Tayyip Erdogan prevedevano che le difficoltà economiche e il malcontento dell’opinione pubblica avrebbero portato a un cambio di governo nelle elezioni presidenziali del maggio 2023. Tuttavia Erdogan si è assicurato un altro mandato di cinque anni, continuando a governare per due decenni.
Le elezioni locali del 2024 hanno dipinto un quadro diverso, tuttavia, con il principale partito di opposizione, il Partito Popolare Repubblicano (CHP), che ha ottenuto vittorie significative in città importanti come Istanbul, Ankara e Izmir, e ha conquistato città tradizionalmente forti dell’AKP lungo il Mar Nero e l’Anatolia. I risultati hanno infuso un rinnovato senso di speranza e motivazione tra i sostenitori dell’opposizione, che si erano demoralizzati dopo anni di sconfitte.
Questo sviluppo ha inferto un colpo significativo alle ambizioni di Erdogan, soprattutto perché sperava di recuperare il controllo delle città meno di un anno dopo essersi assicurato un terzo mandato presidenziale. In risposta, egli ha promesso di correggere le questioni chiave che hanno portato alla sconfitta elettorale del suo partito, in particolare l’aumento dell’inflazione. In un gesto di riconciliazione, Erdogan ha avuto colloqui con il leader del CHP per la prima volta in quasi otto anni, segnalando un potenziale cambiamento nel panorama politico turco.
Il mandato di Erdogan ha visto cambiamenti drammatici nel rapporto della Turchia con l’UE. Inizialmente, il Paese ha fatto passi da gigante verso la candidatura all’UE, attuando riforme chiave e registrando una crescita economica che ha reso il Paese un partner apprezzato. Tuttavia, il secondo decennio di Erdogan ha visto un pivot verso le alleanze orientali e un aumento del sentimento anti-UE per rafforzare la sua popolarità interna. L’ultima relazione dell’UE sui progressi compiuti ha citato come ostacoli al progresso l’incapacità della Turchia di sostenere lo stato di diritto, i valori democratici e i diritti umani, nonché la disputa irrisolta con i ciprioti greci e turchi. Nonostante i tentativi di Erdogan di collegare il processo di adesione della Turchia all’UE ad altre questioni geopolitiche, come l’adesione della Svezia alla NATO, le richieste di porre fine ai colloqui di adesione sono cresciute all’interno dell’UE, anche da parte di Paesi come l’Austria.
Tuttavia, i più ampi cambiamenti geopolitici, economici e ambientali hanno fatto sì che le relazioni commerciali tra la Turchia e l’UE si approfondissero. La Turchia sta attivamente potenziando la sua logistica commerciale con l’UE, lavorando per eliminare le quote di transito e snellire le procedure doganali per ridurre i costi commerciali e incrementare le esportazioni. Questi negoziati in corso mirano anche ad alleviare i costi elevati e le condizioni restrittive per i visti che i trasportatori turchi devono affrontare nell’UE. Inoltre, il Green Deal dell’UE, che mira alla neutralità climatica entro il 2050, sta ridisegnando le politiche commerciali, con ripercussioni su partner non UE come la Turchia. La introduzione di misure come il Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) sta spingendo la Turchia ad accelerare le sue iniziative di decarbonizzazione.
La guerra in Ucraina ha avuto un impatto anche sulle relazioni tra Turchia e UE. La Turchia ha cercato di mantenere una posizione neutrale, con Erdogan che ha sottolineato l’impegno della Turchia per l’integrità territoriale dell’Ucraina, pur impegnandosi diplomaticamente con la Russia. Il suo obiettivo è quello di posizionare la Turchia come potenziale mediatore, con una proposta di ospitare i colloqui di pace tra Ucraina e Russia.
La Turchia ha svolto un ruolo chiave nella Iniziativa sul grano del Mar Nero, un accordo mediato con le Nazioni Unite per consentire le esportazioni di grano dall’Ucraina nel corso del conflitto in corso. Questo accordo ha facilitato l’esportazione di milioni di tonnellate di grano ucraino verso i mercati globali, che erano stati precedentemente bloccati a causa della guerra. Il successivo ritiro della Russia dall’accordo non solo ha inasprito le tensioni ma ha anche complicato la posizione della Turchia, mettendo a dura prova le sue relazioni con i membri dell’UE. L’UE, che è stata critica nei confronti di qualsiasi azione percepita come una minaccia alla sovranità dell’Ucraina, ha visto l’approccio neutrale della Turchia con scetticismo.
Nonostante le rafforzate relazioni, sta emergendo un consenso tra la Turchia e l’UE sulla necessità di ridefinire il quadro della loro cooperazione. Mentre i colloqui di adesione rimangono in stallo, un’area di collaborazione continua è quella della migrazione. Nel marzo 2016, l’UE e la Turchia hanno firmato un accordo volto a contenere la “migrazione irregolare” verso l’Europa. Tuttavia, pur ospitando la più grande popolazione di rifugiati al mondo, la Turchia ha ha affrontato critiche per il trasferimento forzato di rifugiati siriani in aree sotto il suo controllo in Siria, con le deportazioni che sono diventate una questione controversa, in particolare durante periodi elettorali. Nel marzo 2024, Human Rights Watch ha riferito che “Mentre la Turchia in passato ha sostenuto che tutti i rimpatri sono volontari, le forze turche, almeno dal 2017, hanno arrestato, detenuto ed espulso sommariamente migliaia di rifugiati siriani, spesso costringendoli a firmare moduli di rimpatrio “volontari” e costringendoli ad attraversare il nord della Siria.’
Egitto
Il panorama politico dell’Egitto è cambiato radicalmente dopo la Primavera araba, in particolare verso la militarizzazione sotto il presidente Abdel Fattah al-Sisi, che ha sostituito il democraticamente eletto, ma sempre più anti-secolare, Mohamed Morsi tramite un golpe militare nel 2013. Le recenti elezioni alla fine del 2023 hanno visto la rielezione di Sisi tra accuse di manipolazioni elettorali e la sua rielezione. Questi sconvolgimenti si sono verificati in concomitanza con gravi sfide economiche, come un’inflazione da record nel 2023, progetti infrastrutturali irrealisticamente ambiziosi e la svalutazione della sterlina egiziana, che ha gettato ampie fasce della popolazione in difficoltà economiche.
Riconoscendo la crisi economica dell’Egitto e i conflitti regionali in corso, la Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen e diversi leader dell’UE si sono recati al Cairo nel marzo 2024 per firmare una Dichiarazione congiunta per un partenariato strategico UE-Egitto. L’accordo prevede un pacchetto di aiuti da 7,4 miliardi di euro destinato a sostenere l’economia egiziana e a gestire la migrazione verso l’Europa, oltre alla cooperazione in iniziative energetiche a basse emissioni di carbonio e a scambi educativi, culturali e giovanili.
Il partenariato mira anche a rafforzare la cooperazione energetica, con l’UE che aumenterà le sue importazioni di gas e di altra energia dall’Egitto per ridurre la dipendenza dal gas russo. L’Egitto ha anche mostrato un forte interesse nel rafforzare la sua cooperazione con l’UE sul Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) per sostenere la sua transizione verde e ridurre le emissioni di gas serra da industrie pesanti come cemento, alluminio e fertilizzanti.
Una componente importante di questa partnership riguarda le misure per “gestire la migrazione”. Questa collaborazione ha suscitato preoccupazioni sul trattamento dei migranti e dei rifugiati, che sono circa 480.000 in Egitto. La mancanza di un quadro giuridico per l’asilo, la dipendenza dall’UNHCR e la crescente ostilità nei confronti dei migranti dell’Africa subsahariana hanno contribuito a rendere sempre più precaria la situazione dei rifugiati.
.L’accordo dell’UE è stato criticato per aver esacerbato le pressioni sui rifugiati, soprattutto quelli provenienti dal Sudan, aumentando i rischi di espulsione e rafforzando le misure di sicurezza alle frontiere. Organizzazioni come il Consiglio olandese per i rifugiati hanno espresso la preoccupazione
che i fondi dell’UE non necessariamente migliorino le condizioni dei rifugiati in Egitto, indicando che l’attenzione potrebbe essere rivolta più a frenare la migrazione che ad affrontare le cause profonde dello sfollamento e a garantire la protezione dei rifugiati.La partnership ha anche attirato l’attenzione per il potenziale rafforzamento di un regime noto per la soppressione delle libertà civili. Sotto il governo di Sisi, le repressioni alla libertà di parola, di riunione e di stampa si sono intensificate, soprattutto durante le elezioni presidenziali. Sono state apportate significative modifiche legali che hanno ampliato la giurisdizione militare sulla vita civile. La legge restrittiva sulle associazioni del 2019 e i nuovi regolamenti del 2024 sottolineano ulteriormente questa stretta, limitando significativamente le attività delle organizzazioni non governative e violando le libertà pubbliche.
Durante eventi internazionali come la COP27, la comunità internazionale ha apertamente criticato la situazione dei diritti umani in Egitto. Sebbene questi forum globali abbiano talvolta costretto il governo egiziano a rispondere alle critiche, i miglioramenti sostanziali rimangono elusivi, mettendo in dubbio gli impegni dell’Egitto nei confronti dei suoi partenariati internazionali.
Tunisia
La Tunisia, un tempo salutata come il faro della Primavera araba, si trova ad affrontare tempi politici incerti con le prossime elezioni presidenziali ancora da fissare per la fine del 2024. Il presidente in carica Kais Saied dovrebbe ricandidarsi. Il suo mandato, dopo la sua controversa presa di potere nel luglio 2021, ha visto lo smantellamento sistematico delle istituzioni democratiche, indirizzando il Paese verso l’autocrazia tra una crescente repressione contro giornalisti, oppositori politici e attivisti della società civile.
Economicamente, la Tunisia lotta sotto il peso del debito estero e delle rigide condizioni del FMI, che ne minano la stabilità macroeconomica. I tassi di inflazione si aggirano intorno all’8,3% e la disoccupazione si attesta a un ostinato 15%. Inoltre, la Tunisia è diventata un nodo centrale nella rotta migratoria del Mediterraneo, in particolare dopo i cambiamenti nei modelli migratori successivi al 2017 dovuti alla repressione in Libia. Il Paese è ora un punto di partenza primario verso l’Europa non solo per i cittadini tunisini, ma sempre più per i migranti dell’Africa subsahariana.
Nel luglio 2023, l’UE entra in un accordo di “gestione della migrazione” con la Tunisia. Sotto la guida dei principali leader dell’UE, questo accordo ha promesso alla Tunisia fino a 1 miliardo di euro in aiuti, a condizione che vengano attuate varie riforme e che venga garantita la cooperazione nella gestione delle frontiere. Un importo fondamentale di 105 milioni di euro è stato stanziato specificamente per migliorare le capacità di controllo delle frontiere della Tunisia, al fine di prevenire l’attraversamento dei migranti verso l’Europa. Tuttavia, nonostante l’accordo, le partenze dalla Tunisia verso l’Europa sono continuate ad aumentare costantemente.
L’accordo è stato ampiamente criticato dalla società civile, per varie ragioni. In primo luogo, ha coinciso con un aumento della repressione all’interno della stessa Tunisia, con il governo accusato di varie violazioni dei diritti umani, anche nei confronti dei migranti. L’attenzione dell’UE per il controllo delle frontiere è stata vista come complice di questi abusi, dal momento che ingenti finanziamenti dell’UE sono stati indirizzati alle forze di sicurezza coinvolte. Questo ha a sua volta sollevato concerti sull’impegno dell’UE verso gli standard dei diritti umani.
I rapporti si sono ulteriormente deteriorati dopo che la Tunisia ha restituito i fondi dell’UE, in un contesto di escalation delle tensioni tra Bruxelles e Tunisi per il controverso accordo sui migranti. La Commissione ha confermato che la Tunisia ha restituito 60 milioni di euro nel settembre 2023. Questo è stato un duro colpo per l’accordo sui migranti firmato dalla Commissione europea con la Tunisia a luglio, che offriva denaro in cambio di aiuto per arginare i flussi di migranti attraverso il Mediterraneo verso l’Europa. L’UE prevede di fornire fino a 164,5 milioni di euro in tre anni alle forze di sicurezza tunisine. Con una parte significativa destinata alla sicurezza e alla gestione delle frontiere, le implicazioni per i diritti umani rimangono critiche.
Mentre l’impegno dell’UE con la Tunisia si è concentrato sulla migrazione, la sua attenzione si sta espandendo anche verso la diversificazione energetica, in particolare nell’ambito della REPowerEU iniziativa, per passare dalla dipendenza dal gas russo e da altri combustibili fossili a fonti energetiche sostenibili come l’idrogeno. La Tunisia si sta posizionando come partner cruciale in questa trasformazione, pianificando di avviare le esportazioni di idrogeno rinnovabile verso l’Europa tramite gasdotti già nel 2030. Il Paese punta a consegnare 6 milioni di tonnellate annue entro il 2050, collocandosi accanto a Marocco, Algeria ed Egitto come potenziali fornitori chiave di idrogeno all’UE.
Tuttavia, questi piani ambiziosi hanno suscitato notevoli controversie. I critici, in particolare quelli di Corporate Europe Observatory, hanno definito la strategia un “accaparramento neocoloniale di risorse”. Essi mettono in dubbio l’opportunità di utilizzare le limitate risorse rinnovabili del Nord Africa prevalentemente a vantaggio dell’Europa. Anche la fattibilità della produzione di idrogeno per raggiungere questi obiettivi è sotto esame. Sono state sollevate preoccupazioni per gli alti costi e la bassa efficienza energetica della produzione di idrogeno per l’esportazione, che potrebbe trascurare le esigenze ambientali locali essenziali, minando l’agenda della sostenibilità regionale.
Libano
Il Libano è stato messo a dura prova da molteplici crisi. La guerra in corso nella vicina Siria dal 2011 ha spinto circa 1,5 milioni di rifugiati in Libano; con una popolazione totale di 6 milioni di abitanti, questo dà al Paese il più alto tasso di rifugiati pro capite a livello globale. Questa situazione è stata esacerbata da una devastante crisi economica iniziata nel 2019 e aggravata dalla pandemia COVID-19, che ha fatto precipitare circa l’80% dei libanesi popolazione nella povertà, con il 36% che vive al di sotto della soglia di povertà estrema.
La crisi si è aggravata il 4 agosto 2020, con l’esplosione del porto di Beirut, che ha ucciso 218 persone e ha causato danni materiali estesi stimati fino a 4,6 miliardi di dollari. Il disastro ha colpito oltre la metà dei centri sanitari della capitale e il 56% delle sue imprese.
La governance del Libano è afflitta da corruzione e inefficienza e si colloca al 149° posto su 180 nella classifica di Transparency International’s corruption index. Il suo sistema politico, basato sulla condivisione del potere tra vari gruppi settari, non è riuscito a funzionare in modo efficace, con nessun bilancio approvato in oltre un decennio e frequenti accuse di acquisto di voti e interferenze elettorali. Il permanente stallo politico ha lasciato il Libano senza un presidente dalla fine del 2022 e il Paese opera attualmente sotto un governo ad interim con poteri limitati.
La popolazione rifugiata in Libano si trova ad affrontare una situazione umanitaria disastrosa. I rifugiati, tra cui circa 815.000 individui registrati presso le Nazioni Unite, lottano con dure condizioni di vita caratterizzate da alloggi inadeguati, accesso limitato all’assistenza sanitaria e insicurezza alimentare dilagante. Travolto da crisi economiche e politiche, il governo libanese ha bloccato la registrazione di nuovi rifugiati nel 2015, complicando gli sforzi di sostegno.
Ma si prevede che i numeri cresceranno con l’arrivo di altri richiedenti asilo dalla Palestina e da altre guerre in corso nella regione. Secondo Human Rights Watch, “le recenti decisioni di molti Stati membri dell’UE di sospendere i finanziamenti all’Agenzia delle Nazioni Unite per il Soccorso e l’Occupazione dei Rifugiati Palestinesi nel Vicino Oriente (UNRWA), che fornisce assistenza a 250.000 palestinesi in Libano – l’80% dei quali vive già sotto la soglia di povertà – hanno messo ancora più a dura prova la popolazione libanese di rifugiati”.’ Il Libano ha anche ricevuto solo il 27% dei finanziamenti globali richiesti per la risposta ai rifugiati siriani nell’anno precedente, con un impatto significativo sulla capacità di mantenere i servizi di base per queste popolazioni sfollate.
In risposta a queste crisi, l’UE ha concluso un accordo all’inizio di maggio 2024 per fornire al Libano 1 miliardo di euro in tre anni. Questi aiuti mirano a stabilizzare l’economia libanese e a controllare il crescente numero di rifugiati diretti in Europa. Tuttavia, l’accordo ha sollevato preoccupazioni sull’approccio dell’UE alla gestione dei flussi migratori, che spesso privilegia il controllo delle frontiere rispetto alla tutela dei diritti umani.
Le organizzazioni per i diritti umani hanno lanciato un allarme sul trattamento dei siriani rimpatriati con la forza nel loro Paese d’origine. Rapporti di Amnesty International, Human Rights Watch e il Rete Siriana per i Diritti Umani descrivono dettagliatamente gli abusi sistemici perpetrati dalle forze di sicurezza siriane e dalle milizie affiliate al governo. Questi includono detenzioni arbitrarie, torture, sparizioni ed esecuzioni extragiudiziali, che spesso prendono di mira individui percepiti come affiliati a gruppi di opposizione solo perché hanno cercato rifugio all’estero – una chiara violazione del principio di non-refoulement, una pietra miliare del diritto internazionale che proibisce il ritorno di individui in paesi in cui affrontano serie minacce alla loro vita o alla libertà.
Unione a un bivio
Oggi l’Unione europea si trova a un bivio in politica estera. I partenariati dell’UE con i Paesi terzi mediterranei, pur essendo complessi e sfaccettati, continuano a essere influenzati da una storica mentalità neocoloniale che privilegia gli interessi strategici rispetto a partenariati equi. Questa congiuntura critica pone l’UE di fronte a una scelta cruda: continuare con le sue attuali tattiche di commercio unilaterale e di estrazione delle risorse o orientarsi verso relazioni realmente cooperative che rispettino la sovranità e la progressione economica di queste nazioni.
Nel campo della migrazione, l’UE si trova di fronte a un dilemma simile: persistere con strategie di esternalizzazione dei confini che spesso compromettono i diritti umani o adottare un approccio più olistico che affronti le cause profonde della migrazione e dello sfollamento. Questo momento offre all’UE l’opportunità di rivalutare e riallineare le sue politiche per sostenere meglio i suoi valori autoproclamati di promozione della pace, della stabilità e della prosperità.
Tuttavia, la potenzialità di un parlamento più a destra dopo le elezioni pone il rischio sostanziale di approfondire queste pratiche inique, perpetuando l’eredità dello sfruttamento in vesti moderne. La recente approvazione del Patto per la Migrazione dell’UE che incoraggia l’uso di tecnologie di sorveglianza e monitoraggio, suggerisce inoltre che le politiche di esternalizzazione si intensificheranno, portando a un approccio moralmente compromesso e strategicamente sbagliato.



